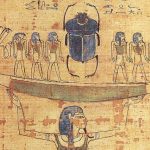Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell’Atene antica
© Cinzia Bearzot. Bari: Gius. Laterza & Figli, 2013.
INTRODUZIONE
Lo storico Tucidide fu un grande ammiratore di Pericle. Fu invece un detrattore della generazione dei suoi successori, quella che R. Connor ha definito dei «nuovi politici», o meglio dei «demagoghi», usando un termine greco in accezione moderna.
Convinto che la democrazia diretta di Atene, data la delicatezza del regime assembleare, potesse funzionare solo in presenza di una leadership eccezionale, Tucidide individuò in Pericle il leader per eccellenza e nei suoi degeneri successori l’elemento di involuzione che portò la democrazia ateniese alla profonda crisi manifestatasi nei colpi di Stato del 411 e del 404 (1).
Nel capitolo 65 del II libro Tucidide traccia, sul modello di Pericle, il ritratto del politico ideale: dotato di moderazione (metriotes), di preveggenza (pronoia) e di intelligenza politica (gnome), autorevole per tradizione familiare e per merito personale, incorruttibile al denaro, Pericle non aveva bisogno di accattivarsi con la demagogia il consenso popolare e seppe quindi instaurare con l’assemblea del popolo, il demos, un rapporto disinteressato e costruttivo, volto al bene comune, tenendolo a freno senza limitarne la libertà. A parole vi era dunque ad Atene una democrazia; di fatto, il governo del protos aner, del primo cittadino. Un ritratto quasi agiografico, che oscura completamente il dibattito contemporaneo sulla figura di Pericle, fatto oggetto di diverse accuse tra cui quella, cui l’immagine del protos aner vuole certamente contrapporsi, di tirannide. Del resto, lo stesso Pericle, secondo Tucidide, si sarebbe presentato all’assemblea in modo analogo, come «l’uomo più di ogni altro capace di prendere le necessarie decisioni e di spiegarvele, amante della città e superiore al denaro» (II, 60, 4-5) (2).
Completamente diverso è il ritratto che Tucidide traccia degli uomini politici che succedettero a Pericle dopo la sua morte, nel 429. Già all’inizio del capitolo 65 lo storico, per difendere Pericle dalle accuse in merito all’esito negativo della guerra del Peloponneso, avverte che gli Ateniesi, invece di seguirne i consigli (non gettarsi in imprese sconsiderate, prendersi cura della flotta, non ampliare l’impero nel corso della guerra, non far correre pericoli alla città), «fecero tutto il contrario e per ambizione e vantaggi personali decisero – con svantaggio proprio e dei loro alleati – imprese che sembravano estranee alla guerra e che, se fossero riuscite, avrebbero portato gloria e vantaggi soprattutto ai privati cittadini, mentre, se fossero fallite, si sarebbero rivelate un danno per la città, considerando le esigenze della guerra».
Fin da principio, dunque, Tucidide contrappone il superiore disinteresse di Pericle e le ambizioni personali, politiche (idiai philotimiai) e di guadagno (idia kerde), dei suoi successori. Una volta presentato il ritratto di Pericle, Tucidide sviluppa ulteriormente la contrapposizione con i successori, che, privi delle sue eccezionali doti e più uguali tra loro, aspiravano ognuno a primeggiare; ma avendo bisogno, a questo scopo, del consenso popolare, furono costretti a compiacere il popolo, dandogli un potere eccessivo e incontrollabile. Ciò fu causa di molti errori; e pericolose fratture civili sorsero da discordie private relative all’assunzione della guida del popolo.
La generazione politica postpericlea è descritta, in modo fortemente unitario, come caratterizzata dal desiderio di primeggiare, dall’interesse privato, dall’impostazione di un diverso rapporto con il popolo, non più libero e disinteressato, ma di reciproca dipendenza: l’uomo politico ha bisogno del popolo, da cui deriva il suo potere, e parla quindi per compiacerlo (la hedoné, il «piacere», il «compiacimento», che Pericle rifiutava), e contemporaneamente il popolo diviene una massa di manovra nelle mani del leader, che ha interesse ad eccitarne le passioni (l’orghé, l’«ira», che Pericle sapeva tenere a freno). Il tema dell’interesse comune passa decisamente in secondo piano; al politico democratico si sostituisce il demagogo, nel senso moderno del termine.
È interessante notare che la stessa valutazione torna in Tucidide a proposito di Teramene, uno dei protagonisti, forse il più significativo, della crisi politica di fine V secolo. In VIII, 89, 3 lo storico ricorda il ruolo di Teramene, che era stato uno dei sostenitori del regime, nella caduta dell’oligarchia dei Quattrocento, che aveva ormai perso credibilità e consenso e da cui egli cercava di prendere per tempo le distanze per non essere travolto dalla sua fine. Parlando degli argomenti messi in campo da Teramene e dai suoi contro i Quattrocento, Tucidide dice:
“Era questo un genere di discorsi di cui si servivano soltanto in pubblico, mentre in realtà i più si impegnavano in tali sforzi solo per ambizioni private, sforzi che più di ogni altra cosa sono destinati a rovinare un’oligarchia nata da una democrazia. Subito infatti tutti pretendono di essere non uguali, ma ciascuno vuol essere di gran lunga il primo fra tutti, mentre uno sopporta più facilmente le conseguenze di una scelta democratica, perché non si considera danneggiato dai suoi pari […] per cui ciascuno di loro gareggiava per essere capo del popolo”.
L’affinità tematica non può sfuggire, anche per la precisa ripresa terminologica, con l’uso insistito del vocabolario del «privato» e del «primeggiare». Tucidide, in II, 65 e in VIII, 89, formula dunque un giudizio unitario su una generazione che ritiene incapace di prendere a cuore l’interesse comune, priva di riferimenti ideali e chiusa in un personalismo sterile e dannoso per le comunità. Se Pericle aveva saputo assolvere il suo compito, mantenendo sicura la città e rendendola grandissima (II, 65, 5), i suoi successori, preoccupati del consenso e del potere, hanno perso di vista questo obiettivo, spingendo la città ad imprese in grado di portare «gloria e vantaggi soprattutto ai privati cittadini» (II, 65, 7). Lo storico ritiene questa generazione politica responsabile ultima delle discordie civili che afflissero Atene nel 411 e nel 404 e, in fondo, della stessa sconfitta in guerra, che la crisi intestina affrettò.
Tucidide guarda infatti alle vicende che narra con la consa pevolezza della duplice crisi democratica di fine secolo e, tra gli obiettivi che si pone, vi è certamente anche quello di capire «come si abbatte una democrazia». Molto attento e sensibile alle «tecniche» dei due colpi di Stato, Tucidide lo è ancora di più al problema cruciale della leadership. Ed è dunque della generazione di uomini politici postpericlei, formatisi nel medesimo ambiente culturale fortemente influenzato dalla sofistica, e quindi molto disincantati sia rispetto ai valori tradizionali sia rispetto alle ideologie, che tratterà soprattutto questo libro. Tucidide comprende certamente, in questa generazione, anche esponenti democratici, come Cleone e Iperbolo; tuttavia, qui ci limiteremo a considerare personalità politicamente più ambigue, da Alcibiade ai protagonisti dei colpi di Stato di fine V secolo. Per capire quale fu il ruolo, nella crisi della democrazia ateniese, di una classe politica di cui si poteva affermare, come fa Lisia (XXV, 8), che «nessun uomo è per natura né oligarchico né democratico, ma ognuno cerca sempre di istituire il tipo di governo che per lui è più vantaggioso» (3); ma anche per trovare, all’interno di questa stessa classe, figure capaci di spiegarne la rapida e inopinata resurrezione.
Notas
1 Tutte le date, salvo diversa indicazione, sono da intendersi avanti Cristo.
2 La traduzione dei passi di Tucidide è di F. Ferrari (Tucidide, La guerra del Peloponneso, I-III, Milano 1985), talora con adattamenti.
3 La traduzione dei passi di Lisia è di E. Medda (Lisia, Orazioni, I-II, Milano 1991-1995).
Bibliografia
Una sintesi recente, sensibile ai problemi che qui si trattano, è quella di L. Canfora, Il mondo di Atene, Roma-Bari 2011, in particolare pp. 206-422. L’espressione «nuovi politici» risale al volume di W.R. Connor, The New Politicians of Fifth-Century Athens, Princeton (N.J.) 1971. Sui demagoghi è importante la sintesi di Chr. Mann, Die Demagogen und das Volk. Zur politischen Kommunication im Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Klio Beihefte, N.F. 13), Berlin 2007.
Sul pensiero democratico il riferimento fondamentale è D. Musti, Demokratia. Origini di un’idea, Roma-Bari 1995. Su Pericle, si vedano A. Banfi, Il governo della città. Pericle nel pensiero antico, Bologna 2003; C. Mossé, Pericle. L’inventore della democrazia, trad. it., Roma-Bari 2006 (ed. or. Paris 2004); C. Bearzot, Pericle, Atene, l’impero, in Storia d’Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico, II. La Grecia, IV. Grecia e Mediterraneo dall’età delle guerre persiane all’Ellenismo, Roma 2008, pp. 289-320.
Il funzionamento istituzionale della democrazia ateniese è stato oggetto di numerosi studi di M.H. Hansen, di cui si ricorda qui, in particolare, La democrazia ateniese nel IV secolo a.C., trad. it., Milano 2003 (ed. or. Oxford 1987).
Strumenti per la lettura di Tucidide sono i due commenti principali dedicati all’opera dello storico: A.W. Gomme, A. Andrewes, K.J. Dover, A Historical Commentary on Thucydides, 5 voll., Oxford 1950 2-1981; S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, 3 voll., Oxford 1991-2008. Per il II libro, in particolare, cfr. anche U. Fantasia, in Tucidide, La guerra del Peloponneso. Libro ii, Pisa 2003. Per Senofonte, continuatore di Tucidide a partire dall’autunno del 411, è disponibile fino a IV, 2, 8 il sintetico commento di P. Krentz, Xenophon, Hellenika, 2 voll., Warminster 1989-1995.
Sulla Costituzione degli Ateniesi di Aristotele si veda il commento di P.J. Rhodes, A Commentary to the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford 1981. Su Diodoro (XIII libro), D. Ambaglio, Diodoro Siculo, Biblioteca, Libro XIII. Commento storico, Milano 2008; inoltre, C. Bearzot, Eforo e Teramene, MeditAnt 14 (2012), pp. 293-308.
Sui colpi di Stato è molto importante la testimonianza di Lisia, che ha attirato negli ultimi anni l’attenzione della critica: cfr. C. Bearzot, Lisia e la tradizione su Teramene. Commento storico alle orazioni XII e XIII del corpus lysiacum, Milano 1997; inoltre, i saggi raccolti in Ead., Vivere da democratici. Studi su Lisia e la democrazia ateniese, Roma 2007; ora, con prospettiva in parte diversa, anche D. Piovan, Memoria e oblio della guerra civile. Strategie giudiziarie e racconto del passato in Lisia, Pisa 2011.
Per le informazioni di carattere prosopografico cfr. J.S. Traill, Persons of Ancient Athens, 18 voll., Toronto 1994-2009.
Baixe a íntegra do texto em PDF: Libro-Come-si-abbatte-una-Democrazia-Tecniche-di-Colpo-di-Stato-nellAtene-Antica-Cinzia-Bearzot-2013
INDICE DEL VOLUME
Introduzione
1. L’uomo della svolta
1.1. Gli esordi
1.2. La spedizione di Sicilia: un’impresa autopromozionale
1.3. Lo scandalo delle Erme e dei Misteri: Alcibiade in esilio
1.4. La fine della spedizione di Sicilia e le prime misure «di emergenza»
1.5. La questione del richiamo di Alcibiade
1.6. Alcibiade egemone autokrator: la fine dell’avventura
2. Il colpo di Stato del 411
2.1. I protagonisti
2.1.1. Antifonte: l’ideologo
2.1.2. Pisandro: l’uomo d’azione
2.1.3. Frinico: il critico
2.1.4. Teramene: il trasformista
2.2. Tecnica di un colpo di Stato
2.2.1. Le società segrete e la manipolazione delle istituzioni
2.2.2. La propaganda: l’emergenza, la salvezza della città, la «democrazia diversa»
2.2.3. Intimidazione, violenza, terrorismo
2.3. La controrivoluzione di Samo
3. Il processo agli strateghi delle Arginuse
3.1. Il processo: la giustizia democratica manipolata
3.2. Teramene: il regista
3.3. Una revisione parziale
4. Il colpo di Stato del 404
4.1. I protagonisti
4.1.1. Teramene: il traditore
4.1.1.1. Le trattative dopo Egospotami
4.1.1.2. L’avvento dei Trenta Tiranni
4.1.2. Crizia: il tiranno
4.2. Tecnica di un colpo di Stato
4.2.1. Le società segrete e il «governo ombra»
4.2.2. Propaganda e intimidazione
4.2.3. I processi politici contro i leader democratici
4.2.3.1. Cleofonte
4.2.3.2. Gli strateghi e i tassiarchi
4.2.4. All’ombra di Sparta: i collaborazionisti
5. La restaurazione democratica. Trasibulo e gli antichi valori
5.1. La concordia
5.2. La salvezza dello Stato
5.3. La costituzione patria. Trasibulo e la patrios politeia democratica